Il noto regista prova a fare un'autopsia ai sentimenti ma riesce solo a tagliarsi le dita
di Luigi Furno
Premessa
Scrivo queste parole sul nuovo spettacolo di Melchionna come si dona una limitatissima testimonianza a una molecola d’infinito supponibile. Un parto complesso e combattuto. La critica deve ritornare a vivere e superare, di gran lunga, il suo oggetto. L’estetica deve ritornare a dominare il dibattito della cosa pubblica. Scrivere di teatro, trattandolo male se è il caso, deve assorbire tutta la funestità del mondo. Il Teatro digerisce il cervello malato, mentre gli arriva a gran bocconi l’assenza intorpidita. Quale enterologo ha un’idea di questo? Solo il Teatro conosce bene l’intestino perché sa far godere, e far cacare.
Tre marmitte abbattono le frequenze sonore dello scoppiamento. Ogni secolo di storia umana è Sfinge. Basterebbero tre marmitte anche per gli affetti per annullare il tuono dei loro scoppiamenti? Probabilmente no. L’udito, e l’orecchio come suo apparato, è il senso più meschino perché non si lascia disattivare come la vista, il gusto o l’olfatto. Lo si annulla solo da fuori, mai da dentro. E così, siamo costretti ad ascoltare, ad infinitum, gli scoppiamenti degli amori. È tanto semplice, rincuorante, ma nelle rapide furiose del declino amoroso, le marmitte sfiatano un borbottio di rancore, piccole sevizie, escoriazioni superficiali che non hanno abusato per niente del reale, finendo i loro poveri giorni nella virtualità, nel vorrei quello, vorrei solo quello, e lentamente, in questo mondo di aquilotti accecati, l’amore, che ci ha dissanguato il buon senso, perisce, solo e fragile. Questo silenzio che resta dell’amore è il silenzio garantitoci da un motore a scoppio. Una Rolls-Royce fa più timore di una coppia innamorata che esplode con una detonazione sincronizzata. “A 60 miglia all’ora, il rumore più forte della nuova Rolls-Royce proviene dall’orologio elettrico”.
Una delle campagne pubblicitarie più celebri e di successo mai realizzate risale al 1955, e fu scritta da David Ogilvy per la Rolls-Royce. La forza di questa campagna sta nell’aver individuato, tra tutte le possibili caratteristiche di un’automobile, quella più sorprendente ma allo stesso tempo più inattesa. La macchina a scoppio non fa alcun rumore. Per Luciano Melchionna, invece, lo scoppio dell’amore è una sarabanda rumorosa.
Mi torna in mente Asimov mentre varco il cancello di uscita del teatro De Simone - in cartellone, “L’amore per le cose assenti”, regia di Luciano Melchionna - e quel suo testo curioso sul “Duemila visto dall’Ottocento” che correda, anni dopo, una cinquantina di cartoline originali commissionate nel 1899 ad un tale illustratore, Jean Marc Coté, per celebrare l’avvento del nuovo secolo. Ma, quello che penso e mi incupisce è come sia stato possibile invertire, spudoratamente, il fascino distopico di Asimov con il lubrico, monomaniaco, elucubrare d’amore melanconico, manco fossimo ancora con le fette di prosciutto sugli occhi nel pieno fervore del Romanticismo tedesco. Cosa c’è capitato per far somigliare i rapporti di coppia a quella specie di insorgente tendenza spiccata al coltivare ortaggi, mettere su orti, potare, innaffiare, accudire piante? E poi parlarne, parlarne a lungo tra aperitivi annacquati e sigarette di tabacco sciolto. Quale malanno abbiamo alle meningi, per credere attuale e coreutico una danza di riflessioni e analisi amorose che era marcia già nel finire dell’Ottocento, Ibsen e Strindberg ce l’hanno largamente fatto notare, e che, oggi, è un reliquiario di banalità per una borghesia fancazzista? Cosa ci spinge a maltrattarci tanto, a illividirci sadicamente, a masturbarci il quieto vivere, per trasformare un legame amoroso in un melodramma psicotico? Non c’è risposta, e di sicuro non la troviamo nello spettacolo di Melchionna, che si limita alla scialba descrizione di situazioni verosimili di una coppia che scoppia, ma non come una Rolls-Royce, in silenzio, ma facendo un baccano ciarliero da centro commerciale. Ci sono tante parole ma sono vuote a perdere. “Non mi tiri più”, “la mia fica è slabbrata da 10 cazzi e oltre”. E queste cose dovrebbero ferire? Sono lame stagliate che non recidono nessun tendine. Parole che limitano il loro senso alla pura significazione, non dicono niente di più di quello che vogliono indicare. Sono un dito che indica la Luna, e tutti a guardare il dito. Possiedono un orizzonte semantico semplice, da prima serata. Sono parole targettizzate costruite con una meccanica pavloviana per essere deglutite sbavando di piacere.
Del mimetismo l’operazione di Melchionna ha poco, è infatti una pura simulazione che assume le forme e i colori del contesto, quello del rapporto di coppia, ma solo per confondere il predatore, l’osservatore, e metterlo nella posizione a sua volta di osservato, forse anche di minacciato, rovesciamento della piramide della visione, come ha mostrato Jacques Lacan sulla scorta di Roger Caillois. L’operazione è, probabilmente inconsapevolmente, furba. Non si tratta cioè né di far sentir preda della manipolazione né di illudere di diventare il predatore che, svelando la manipolazione, crede di averla vinta. Si tratta piuttosto di cambiare la tattica, di mostrare le cose nella pura attrazione scenica e farle sembrare una descrizione puntuale delle vite di tutti. Il pubblico crede che quello che sta vedendo sia una sorprendente messa a nudo della propria intimità, senza accorgersi, e questo è veramente sorprendente, che è un’intimità tanto prostituita da doverla condividere con tutti. Crede di farsi un’autopsia dei propri sentimenti e, invece, si sta solo mirando ad uno specchio che alimenta la propria perversione narcisistica. Nell’Epilogo, un’interprete in un ruolo metanarrativo dice: “Beh? Che fate lì fermi? Spiate la loro intimità? Guardate pure, ora? Non vi basta aver annusato a lungo nei loro panni sporchi? Esservi specchiati nello smarrimento del loro malessere? Dite la verità: vi siete riconosciuti, qua e là? Andrete a casa riflettendoci su, come spero? Cercherete di migliorare la qualità dei vostri rapporti…?”.
Se la macchina psichica messa su da Melchionna funziona perfettamente, il pubblico deve rispondere sì a tutte queste domande. Lo spettatore deve avere la sensazione pura che lì sopra si sta parlando intimamente di sé. Ed è quello che accade.
Ma tale macchina psichica, dal mio punto di vista, è tarata male perché è solo una macchina descrittiva e non un “truthiness”, termine che non esiste nel dizionario ma è in uso nell’inglese parlato. Deriva da “truth”, verità, ma ha piuttosto a che fare con “ciò che ti aspetti che i fatti siano, come opposto a ciò che sono”, ovvero “uno scherzo su verità e falsità che è a sua volta una bugia, una bugia che si dice per rivelare una verità più grande sotto di essa”. Un teatro “truthiness”, è evidente, altera i giochi di rispecchiamento, anzi, lo specchio s’inclina e si deforma, non ci si riconosce in niente di quello che si vede, non attira applausi a scena aperta perché non è adatto ad un pubblico abituato alle prime serate televisive. Un teatro così, non assomiglia al vissuto di nessuno, perché lo squarcia e non si limita a descriverlo.
Un teatro puramente descrittivo del reale è costruito appositamente per una cultura di “provincia”, ma ormai è tempo di capirlo che c’è un'altra Italia di provincia, aliena da livori di campanile e piena di vita e d’intelligenza spesso più dei grandi centri, che si credono cinema di prima visione e sono talora vecchi teatri di posa in fase di smobilitazione. Questa Italia vuole qualcosa, ma deve soffrire l’assenza.
“Nostalgia del futuro” s’intitolava un altro libro di Asimov, “Nostalgia per un passato assente” dovrebbe essere, invece, il titolo del nuovo spettacolo di Luciano Melchionna ed è la scritta non scritta che ritrovo abbagliante e luminosa, come una scilla ululante, un po’ in tutta la messa in scena. Il titolo invece è “L’amore per le cose assenti”, ed è fin da subito un presagio di illusione. L’assenza viene evocata con una litania ritmica di chiacchiere affinché cambi stato e divenga presenza, ed è intorno a questo passaggio impossibile, perché la vita è viva solo se esiste l’impossibile, che ci si fa del male, in scena, ma è una finta ed è noiosissima. Una coppia, un uomo e una donna, pre-in-post-ex-infra-epi-oltre-ultra-iper-super innamorati rotolano sul palcoscenico in un blablabla di accuse reciproche, ma quello che c’è è solo una pigrizia analcolica, un vomitarsi di accuse che non infamano, non hanno nessuna fame queste accuse perché sono sazissime, è non feriscono, sono coltellacci stagliati, un “mise en scène” al limite della pantomima di una soap opera venezuelana. Non c’è nessuna battuta che ferisca a morte, la tragedia non è archetipica ma solo atteggiata. Le parole sono evanescenti, superflue, galleggiano come il petrolio sull’acqua e non si infiammano. Non hanno la potenza di uno svelamento che squarci il “velo di Maya” delle apparenze. Il teatro di fine Ottocento, romantico o espressionista, aveva già ampiamente scandagliato la psicologia dei giochi di ruolo che si inscenano in un rapporto amoroso, lo aveva fatto con la nobile arte dell’implicito. Carmelo Bene, con uno dei suoi soliti paradossi, un giorno dichiarò che poco dopo aver letto l’Ulisse di Joyce, nacque in lui la speranza che nessun altro romanzo potesse essere scritto dopo. La speranza è stata vana. Dopo la storia di Nora, in “Casa di bambola” di Ibsen, poteva nascere la speranza che sull’argomento si era detto quello c’era da dire. Nora non è solo una bambolina col compito di svagare il marito, ma si rende conto di essere vissuta fino ad allora in un mondo dominato dall'ansia di affermazione, poco attento ai rapporti interpersonali e che finisce con l'inghiottire l'universo interiore degli uomini. Del resto, Ibsen individua col suo lavoro una insanabile frattura tra gli autentici valori della vita e le norme comportamentali imposte dalla società. Tuttavia la provocazione di Nora non si traduce solo nell'affermazione della personalità di ciascun individuo al cospetto di una società ottusa, ma anche nella ribellione di una donna che aspira ad essere considerata "individuo" al pari di chiunque altro. Trattandosi di un testo teatrale, l'evoluzione dei personaggi non scaturisce da analisi della loro psicologia o da penose descrizioni del loro stato d'animo, ma risiede logicamente nelle loro azioni, nei silenzi e nei dialoghi, tanto scarni ed asciutti quanto incisivi.
Non è andata neanche in questo caso così, e si è continuato a scrivere e fare teatro ancora su questi temi, anche dopo una scena così definitiva come questa di Ibsen: "Tu non pensi e non parli come l'uomo di cui possa essere la compagna. Svanita la minaccia, placata l'angoscia per la tua sorte, non per la mia, hai dimenticato tutto. E io sono tornata ad essere per te la lodoletta, la bambola da portare in braccio. Forse da portare in braccio con più attenzione perché t'eri accorto che sono più fragile di quanto pensassi. Ascolta, Torvald; ho capito in quell'attimo di essere vissuta per otto anni con un estraneo. Un estraneo che mi ha fatto fare tre figli... Vorrei stritolarmi! Farmi a pezzi! Non riesco a sopportarne nemmeno il pensiero!"
Dopo questo c’è ancora chi, come Melchionna nel suo spettacolo, pensa di poter fare ancora “un’esilarante, impietosa, autopsia dei sentimenti. Un confronto non più̀ mediato dai sensi di colpa sterminati ormai, implacabilmente, dalla voglia di verità̀ che anima entrambi”.
Non stupisce, quindi, che un titolo, come “L’amore per le cose assenti”, possa essere un presagio, nomen omen come dicevano i latini. Un titolo, così esageratamente connotato, appropriato all’assenza che è la sua essenza, conveniunt rebus nomina saepe suis (spesso i nomi sono appropriati alle cose/persone cui appartengono).
Giulia, la protagonista dello spettacolo, anni prima ha vissuto il naufragio del suo primo matrimonio.
Oggi, colui che vediamo in scena, è il suo secondo marito che ha organizzato per lei una bellissima festa di compleanno... ma non ha invitato nessuno. Vuole restare solo con la moglie, occhi negli occhi, per dirle addio. Il suo regalo di compleanno: la libertà.
Quello che succede dentro il boccascena, una bocca spalancata che non articola la lingua nella parola in quanto ventriloqua e, in ogni modo, il suo dire è sempre altrove, è un potlach eccitato ma mai esploso. Un dispendio di energia analitica destinata a fallire in quanto la dépense (il dispendio), nell’accezione di Georges Bataille, non possiede quella viscosità che può rende eterico ma è, foucaultianamente, legato ad un meccanismo microfisico del potere che gestisce tutto il circolare pseudo-anatomico in scena, come un burattinaio arma il suo burattino. Quello che cercano i due personaggi è un riempirsi di verità vomitando il superfluo, scaricandolo come una zavorra. Dimostrazione perfetta di come l’enfasi, tutta televisiva, di dirsi sempre la verità ad ogni prezzo faccia ormai parte del corredo genetico della nostra più becera retorica. Trasformare l’intera esistenza in una sterminata palude di chiacchiere e riflessioni solo per affinare meglio, e plasmarlo, un presunto ideale di verità da indossare come abito buono della domenica.
Durante la lunga discussione tra i due coniugi emergono tutte le verità celate dal velo di “sopravvivenza e sopportazione” come il senso di frustrazione dovuto dalle difficoltà quotidiane che producono l’infelicità del loro rapporto. Durante lo scontro tra i due, tutto è emotivamente alterato ma il tutto è matematizzato. Due sono le conseguenze più evidenti che si possono trarre: anche l’amore ha un ciclo vitale, nasce, vive, muore, viene mangiato, metabolizzato e trasformato in altro. La biologia, non scientifica ma emotiva, stabilisce che l’amore, come qualsiasi altro organismo vivente, ha una gestazione, nasce, svolge un suo compito, decade e muore (si trasforma). La dimostrazione più ampia di questa matematica dell’amore è che le simmetrie dell’universo si possano ripartire in quattro, poi in otto, poi in sedici e così all’infinito. Il suo enunciato è noto come Enorme Teorema. Dimostrare questa affermazione richiede qualcosa come 15.000 pagine, e i pochissimi che le capiscono temono di morire prima che subentri loro una nuova generazione. I matematici dell’amore hanno lanciato un progetto di salvataggio per semplificare questa dimostrazione e quindi riuscire a salvarla prima che sparisca la conoscenza.
Il cuore dello spettacolo è incorniciato da un prologo ed un epilogo. Il prologo, in un gioco di metateatro, racconta del mondo meraviglioso del teatro dove, però, si riescono a realizzare spettacoli teatrali eccezionali che muoiono per mancanza di fondi. Che spreco! Nuovi testi sono stati scritti, nuovi successi e altre mancanze, fino ad arrivare alla storia di Giulia e suo marito. Nell’epilogo l’accenno di una canzone: “Each man kills the thing he loves” – Ogni uomo distrugge ciò che ama.
Questa idea di sfondamento della quarta parete, attraverso l’epilogo e il prologo, dovrebbe garantire un sapore di classicità ma, così come è stato realizzato, dà l’idea di un Piero Angela che prima ci introduce nel fantastico mondo dei lemuri e poi, dopo averci fatto vedere il documentario sui corteggiamenti e l’accoppiamento, ci spiega che quello che abbiamo appena visto era proprio il corteggiamento e l’accoppiamento tra lemuri, nel caso non fosse stato chiaro nel video.
La scenografia, opera del bravo Roberto Crea, è un grosso cuore naturale, retto in una rete da pesca, che sormonta la scena, un salotto borghese con poltrone e candelieri.
L’atmosfera è surreale ma, forse, l’intera scenografia andrebbe letta come una metafora dell’annegamento e l’intero cubo scenico come una grossa boccia d’acqua. Il cuore, metafora più che abusata per l’amore, è affogato in questa boccia dove i due attori boccheggiano, per tutto il tempo, come due pesciolini rossi e afoni che annaspano in un’acqua salmastra. Il cuore deve essere ripescato, e sarà ripescato sul finale, riportando tutto in superficie.
Nel suo essere carnale, il cuore possiede cavità, aperture, dentro cui si trovano rifugio i due personaggi in scena. L’interno nel cuore carnale è alveo del fiume del sangue versato tra i due, in cui il sangue si divide e torna a unirsi con se stesso.
Il cuore è il vaso del dolore, può custodirlo per un certo tempo ma poi, inesorabilmente, in un attimo lo offre. Ed è allora calice che tutto l’essere della persona è tenuto a sorbirsi. E, se lo fa lentamente con il dovuto coraggio, via via che esso si diffonde per le diverse zone dell’essere, comincia a circolare con il dolore. Il rischio tante volte è che il dolore sia un fatto quasi accidentale, come nel caso dello spettacolo di Melchionna. Che il dolore non abbia essenza, che sia stato cercato nelle sciocchezze del quotidiano anziché nella tragedia dell’esistenza. Che non possa che star lì senza circolare. E che, non circolando, non possa davvero essere assimilato.
Il cuore è un cardiomuscolo che va rianimato, ma nella sua funzione artaudiana di organo da eliminare per la tensione che spinge verso il supposto corpo-senza-organi. In ogni modo, andrebbe disabilitato il legame, ormai apertamente inscindibile, tra il cuore come organo e il sentimento amoroso. E smetterla di scivolare dall’apice testicolare del cranio e autoriempirsi di stupri senza fine, di spiriti innestati sotto il rovescio della lastra degli specchi, nelle vecchia determinazione millenaria ad aspirare alla felicità senza fine.
C’è questa noia informe, una semina di funghi atomici che implora esplosioni apocalittiche ma che nasce, muore, e allo stesso tempo vive, solo su cartoline metaforiche inviate da reduci da una guerra mai combattuta, solo evocata nel rimembrare sciocco del quotidiano. Una Enola Gay scappellata dalla testa di morte che dovrebbe portare. I due attori in scena, sono fantocci animati da un avvalorante sentore di distruzione ma che, sterili come un mulo, si stemperano in un ping pong di stereotipate battute che si lanciano vicendevolmente.
Sembrano ormai capaci soltanto di quella pigrizia che Roland Barthes definisce «imbronciata», carica cioè di tutto il senso di colpa di cui è permeato il loro vivere. Vogliano essere competitivi, sfacciati, in qualche modo portatori di una pace armata, e al passo con il correre del mondo, assomigliargli fino al midollo. Ma dove stanno andando? Sono ancora capaci di sostare senza percepire la sosta come una resa? Cosa abbiamo perso, noi, dopo aver abbandonato il piacere della dissipazione, del tempo e forse non soltanto di quello? Partendo da Roland Barthes, che ci descrive la delizia della pigrizia, e attraverso le parole di Peter Handke e le riflessioni che il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han dedica al tema della stanchezza, provo a ragionare e a chiedermi cosa abbia mai voluto dire Luciano Melchionna con questo spettacolo su questi temi della società contemporanea: il tempo e la pigrizia, l’indugio e la stanchezza, l’accelerazione, l’ozio, lo spreco, e il senso di un tempo senza finalità alcuna e, infine, sui rapporti di coppia che incardinano tutto il tempo della pièce.
Melchionna lo dice apertamente, il suo testo vuole essere una “autopsia dei sentimenti” che ci scavi e ci seghi le gambe. Ma quali gambe ci ha voluto segare Mechionna, quali gambe? Siamo paraplegici dell’amore romanzato, ormai, siamo invischiati nella trama di psicoanalisi spicciole e godiamo nel fare il capello in quattro. Ci aveva già superato Ettore Petrolini quando canzonava Amleto, perso in un flusso di pensieri e non si dedicava ad Ofelia, che nel mentre moriva, con: “L' amore è facile/Non è difficile/Si ha da succedere/Succederà”. Ernesto Murolo, originario autore dei versi, è ben più tragico: “Cu ‘ammore, é facile/tutt”o ddifficile…/Si ha da succedere,/succedarrá!”.
Forse bastava leggersi solo “La ballata del carcere di Reading” di Oscar Wilde per farla finita, in adolescenza, con tutto questo struggimento d’amore. “Eppure tutti gli uomini uccidono ciò che amano,/ Tutti ascoltino dunque ciò che dico:/alcuni uccidono con uno sguardo d’amarezza/altri con una parola adulatoria,/ il codardo uccide con un bacio,/l’uomo coraggioso con la spada!”
“L’amore per le cose assenti”, in definitiva, piacerà ai molti perché è costruito meglio di quello che veramente dice. Ma questo non ci dovrebbe ingannare.
Voti
Attori: 8
Scenografia: 8
Testo: 6
Musiche: 7
Regia: 7
Voto generale: 5
Si noterà una contradizione. Tutti i voti positivi delle singole parti, generano un voto insufficiente per il tutto. Tadeusz kantor diceva: “l’esperienza del xx secolo ci ha insegnato che: la vita nel suo svolgersi e divenire non conosce argomenti razionali". Il giudizio critico è un sistema complesso in cui l’insieme è cosa diversa della somma delle singole parti. In caso contrario, saremmo Tripadvisor.
Pubblicato in origine su bMagazine.it
Pubblicato in origine su bMagazine.it

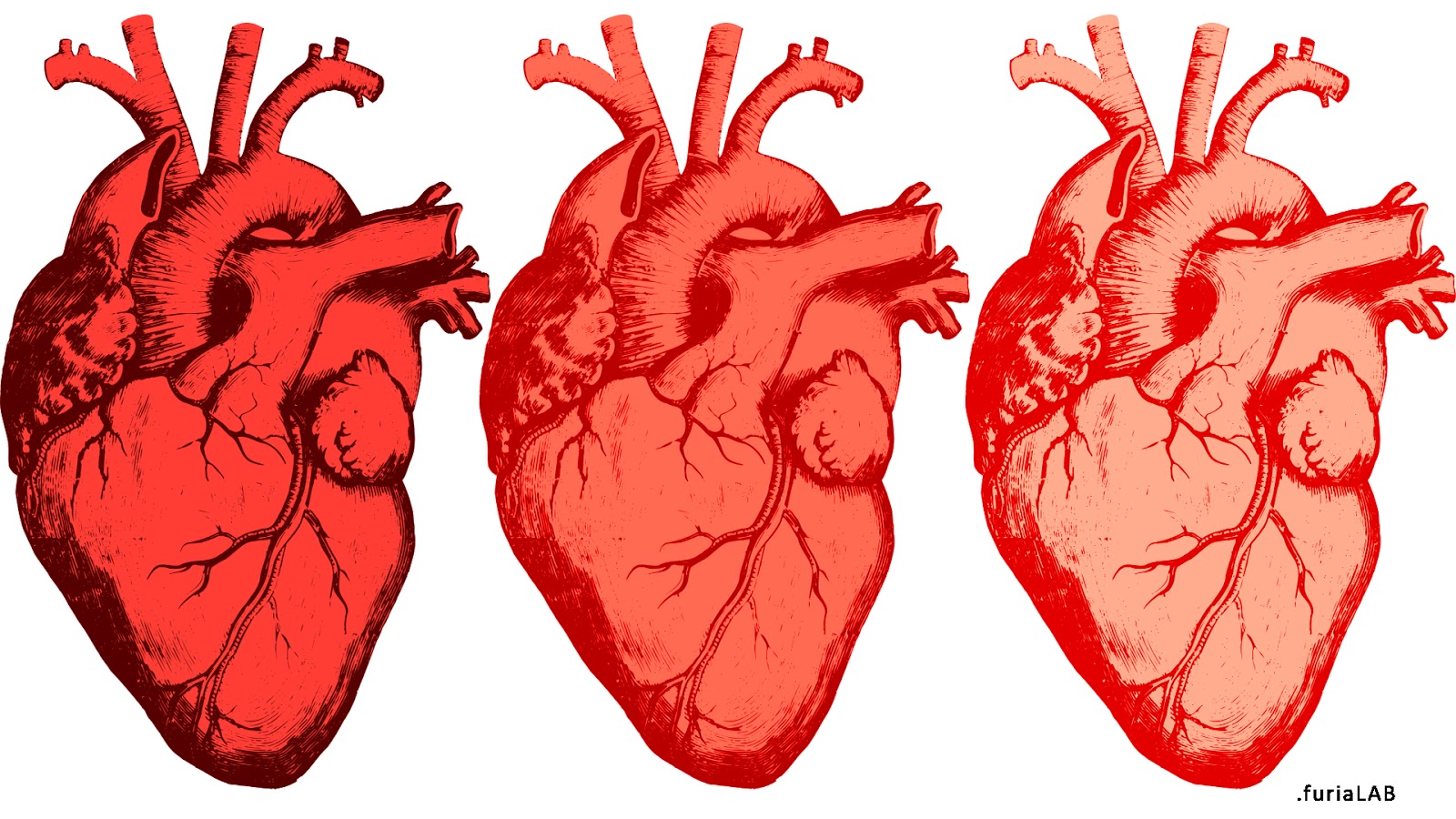







Nessun commento:
Posta un commento